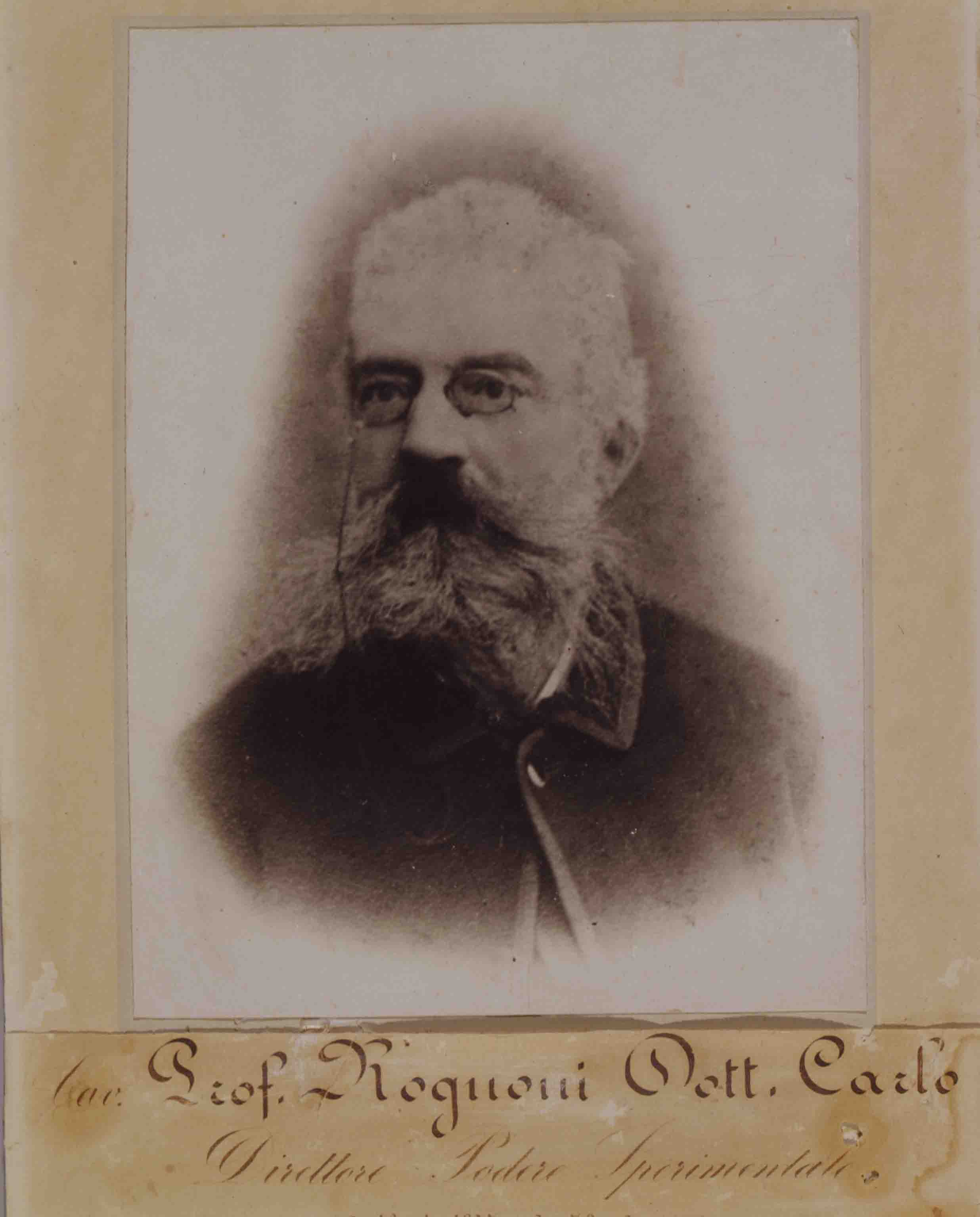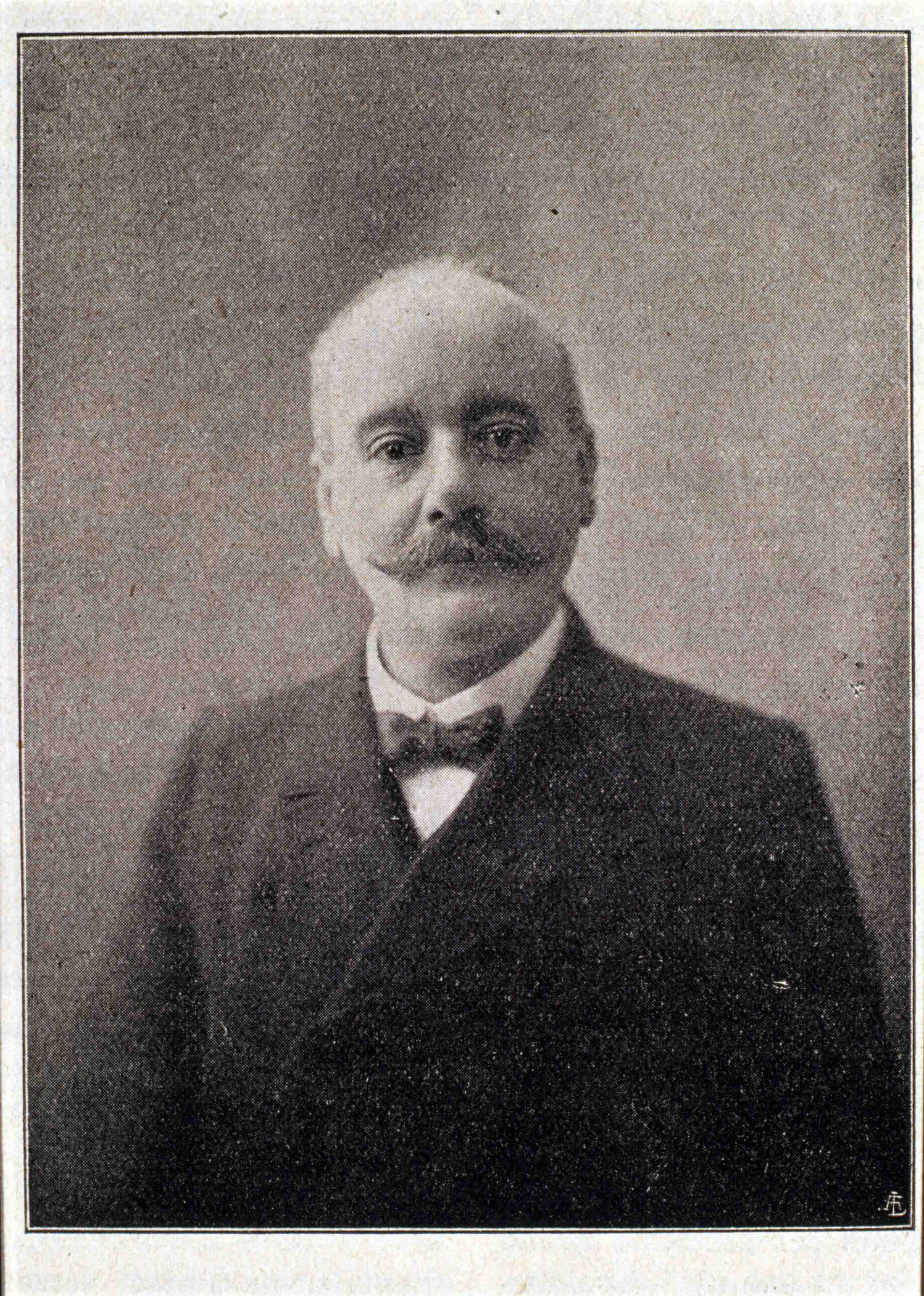Il vino e la sua storia parmense
L’acqua è indispensabile per la vita e il bere è esigenza continua per tutti gli esseri viventi.
Le prime bevande dell’umanità furono il latte, prodotto dai mammiferi per la nutrizione dei cuccioli e l’acqua, presente allo stato naturale, ma che, soprattutto se stagnante, può contenere batteri e portare malattie.
L’esigenza di preservare l’acqua dall’inquinamento batterico, portò alla scoperta di bevande fermentate – quali ad esempio l’idromele (dalla fermentazione del miele), la birra (dalla fermentazione di cereali), e il vino (dalla fermentazione dell’uva) – che costituivano anche un nutrimento facilmente assumibile.
Il vino ha anche la capacità di alterare la mente con euforia o sonnolenza e di donare sensazioni piacevoli, ricercate dall’uomo già in epoca preistorica. È anche un disinfettante e un potente analgesico e per questo motivo ha costituito la più importante sostanza medicinale del mondo antico. Ed è stato utilizzato in cucina per insaporire i cibi.
È un fatto che la storia della nostra civiltà coincide per molti aspetti con la storia del vino.
La diffusione della vite selvatica eurasiatica (Vitis vinifera L. subsp. Sylvestris), che oggi cresce in tutto il bacino del Mediterraneo, attorno alle coste del mar Nero e a Sud del mar Caspio, doveva essere in origine assai più estesa. Ma solo alcune sacche nelle vallate e pianure più basse e riparate dell’area orientale riuscirono a sopravvivere ai rigori del periodo glaciale.
Le leggende identificano nel Vicino Oriente l’area in cui iniziò il processo di coltivazione e domesticazione della vite e di produzione di vino. Gli scavi archeologici sui monti Zagros (tra gli attuali Iran e Iraq), che hanno rivelato i più antichi strumenti legati alla produzione del vino, lo confermerebbero.
Da questa zona, tra il 3500 e il 3000 a. C., il vino si diffuse nelle regioni adiacenti – Egitto e Bassa Mesopotamia – e prima del 2200 a. C. giunse a Creta e quindi in Grecia e in Italia: Roma ne avrebbe diffuso l’uso in tutti i territori del suo vasto impero.
Veniva, infatti, bevuto come aperitivo, durante i pasti e, soprattutto, nel corso delle abbondanti libazioni che seguivano le cene, ma mai puro, perché i Romani ritenevano, a differenza dei Barbari, che dovesse essere abbondantemente annacquato (Ateneo, I deipnosophisti, 2, 36a), per non provocare danni alla mente.
A seconda delle stagioni il vino poteva essere raffreddato con la neve o scaldato col fuoco; diffusissimo era inoltre l’uso di addolcirlo con il miele e profumarlo con foglie di rosa, viola e cedro, cannella e zafferano. Molte erano dunque le qualità di vino presenti sulle tavole dei Romani: bianchi, rossi, secchi, abboccati, a bassa ed alta gradazione, e caratterizzati da un forte invecchiamento.
Le anfore destinate alla vendita erano chiuse con tappi di sughero o ceramica e sigillate con pece, argilla o gesso e venivano poste nelle celle vinarie. Un’iscrizione a pennello sul corpo dell’anfora o un’etichetta (pittacium) ricordavano l’origine del contenuto, mentre per indicare la data, si scriveva il nome dei consoli in carica nell’anno.
Gli Appennini, che segnano un confine climatico preciso, rendono l’Italia settentrionale (Cisalpina) meno adatta alla coltivazione della vite, che fino all’800 a. C. non è documentata nella pianura Padana, dove, al posto del vino, continuavano ad essere prodotte bevande fermentate partendo da cereali, frutta, sorbe, luppolo (noto dal IV secolo a. C.), miele… .
I bicchieri per la birra – come il prezioso reperto scoperto nella necropoli di Golasecca in provincia di Novara nel 1995 databile al VI sec. a. C. – dalla fine dell’età del Bronzo diventano più piccoli perché la gradazione diviene più forte e hanno una strozzatura all’altezza del collo, in modo che la birra produca più schiuma, facilitandone il taglio per asportare la pula galleggiante.
I Celti, dunque, erano abituati anche a birre fortemente alcoliche, che avevano subito processi di invecchiamento in botti di legno, che bevevano senza aggiunta di acqua e che provocavano ebbrezza. Queste abitudini radicate, rimasero anche con l’ampia diffusione del vino, che i Celti bevevano, a differenza dei Romani, puro, nelle varietà frizzanti e schiumose, in bicchieri stretti e alti.
È dunque importante ricordare come proprio nel nostro territorio si consolidasse il “modo” di bere il vino – schietto e in “bicchiere” – che ancor oggi noi conosciamo.
Il grande sviluppo del vino in Italia aveva coinciso con il miglioramento climatico a partire dal IX sec. a. C.
Furono gli Etruschi ad importare presso i Golasecchiani della pianura padana prima il vino (anfore del VII secolo a. C.) e poi la coltivazione della vite.
Fin dall’età del Bronzo era stata fatta una selezione di vitigni selvatici (Avanà in Piemonte e Negrettino in Emilia), su cui poi furono innestati vitigni mediterranei: un esempio è il Nebbiolo.
La tecnica etrusca di coltivazione è quella dell’alberata: le viti vengono “maritate” ad alcuni alberi vivi, cioè fatte crescere in altezza sul tronco e sui rami, che le proteggono dal gelo.
È la tecnica dell’“arbustum gallicum”, ricordata da Plinio (XVII, 212).
Da Marsiglia per i bianchi si diffuse invece la tecnica a sostegno morto cioè su palo (Historie Philippiche XLIII, 4) documentata nel Piemonte meridionale: è la tecnica greca del charax – in dialetto carasso – che prevede l’uso dei pali al posto degli alberi, già descritta da Omero.
Presso i Liguri era stata addomesticata l’uva selvatica locale, ottenendo la Labrusca, antenata del nostro Lambrusco, che dà un vino molto aspro, presto adottato dai Celti: “i Celti delle Alpi sempre coperte di neve e di ghiaccio non possono avere che vino selvatico” (Antologia Greca Planudea IX, Epigr. 561).
Il mondo etrusco fece da mediatore tra le tecniche di invecchiamento celtiche – usate per la birra (botti e aggiunta di luppolo selvatico) che così raggiungeva alte gradazioni alcoliche e veniva consumata pura – e i vitigni mediterranei, che producevano un vino da consumare annacquato.
Inizialmente il vasellame utilizzato per bere il vino era d’importazione etrusca, poi ne venne sviluppato uno locale: dal V secolo a. C. i bicchieri perdono la strozzatura e diventano soprattutto bicchieri da vino.
Tuttavia gli scavi realizzati dalla Soprintendenza in Val Taro a Riccò, di fornaci per la fabbricazione di contenitori da vino per eccellenza, vale a dire doli e anfore che sappiamo prodotte nell’arco di un secolo (fine II sec. a. C. – fine del I a. C.), ci consentono di ipotizzare come già pochi decenni dopo la fondazione della colonia, fossero stati impiantati estesi vigneti nelle colline parmensi, così come documentato dal trattato di agricoltura dei Saserna, originari di queste zone, grazie al miglioramento climatico che si era registrato a partire dalla seconda metà del III secolo a. C..
Il ritrovamento a Pannocchia di una cella doliare in grado di ospitare una settantina di grandi contenitori della capacità di circa mille litri ciascuno (40 anfore) rende l’idea della produzione di una villa rustica del nostro territorio con una vigna di circa 13 iugeri (32 ettari).
Anche nel Parmense l’influenza celtica fu fondamentale per definire le modalità di consumo del vino. Qui l’uso di bere il vino “alla gallica”, cioè puro, non solo sopravvisse, ma con le invasioni germaniche si diffuse maggiormente, al punto da divenire la regola e condizionare ancor oggi i nostri costumi.
La coltivazione della vite, dopo una riduzione registrata durante le invasioni barbariche, legata com’era al culto cristiano, si diffuse progressivamente con l’attività monastica e il vino divenne la bevanda principe in tutta Italia.
La coltivazione della vite e la produzione di vino prosegue, ininterrottamente, per tutto il Medioevo, lasciando numerose tracce nei documenti notarili. Ma anche i “mesi” antelamici del Battistero, che raccontano le principali attività dell’uomo, testimoniano la potatura della vite, la preparazione delle botti e la vendemmia. Nel Rinascimento l’umanista parmigiano Francesco Maria Grapaldo, nel suo De partibus aedium, nel descrivere la casa ideale del suo tempo, si sofferma a lungo sulla cantina ed elenca i vitigni coltivati nel Parmense, fra cui Trebbiano, Vernaccia e Malvasia. Pergolati dipinti di uva si trovano al castello di Torrechiara, nel cosiddetto Palazzetto Sanvitale al parco Ducale, nel Palazzo Sanvitale di città e nel Palazzo Ducale di Colorno.
Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III Farnese nel XVI secolo lascia testimonianza dei vini locali nella sua rinomata opera Della qualità dei vini. In epoca farnesiana il vino parmense è protagonista a Corte nei ricevimenti e nei pranzi e nelle escursioni del Burchiello lungo il Po. In epoca borbonica il Primo Ministro Du Tillot promosse il miglioramento dei sistemi di coltivazione della vite, importando tecnologie più moderne dalla Francia.
Alla fine del Settecento risale un importante manoscritto, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Parma e pubblicato in facsimile dalla Camera di Commercio nel 1964, che descrive la situazione dell’agricoltura parmigiana del tempo. Il capitolo che più ci interessa è quello intitolato “Trattato delle viti e sua coltivazione”, molto ampio e dettagliato, arricchito con gustosi disegni naïf molto efficaci, che testimoniano gli scopi pratici del trattato e il livello tecnico raggiunto nel settore.
Il 24 giugno 1880 scrive da Sant’Agata, preoccupato degli effetti di una gelata dell’inverno precedente, all’amico Arrivabene: “Le viti che furono coperte daranno molta uva, disgraziatamente molte e molte non ne daranno affatto perché gelate. Infine, da noi, annata non abbondante ma sufficiente!”. E da Milano nell’ottobre 1898 Verdi, confermando il suo imminente arrivo, scrive al fattore Balestrieri: “Ripeto ancora di travasare il vino della prima schiacciata, e di cavare il mio che resta ancora nei tini prima del nostro arrivo”. Ordini secchi e precisi, come era suo costume.
Solo pochi viticoltori ripiantarono i vigneti su piede americano, ponendo le basi per il rilancio degli anni Sessanta del Novecento e la costante crescita qualitativa seguita alla nascita, nel 1977, del Consorzio del Vino dei Colli di Parma, che vanta oggi oltre cinquanta soci tra produttori e imbottigliatori.
Questa storia affascinante, che vede il nostro territorio con un ruolo centrale nel processo di cambiamento del modo di bere il vino, è ora raccontata dal Museo del Vino, allestito nelle cantine della Rocca di Sala Baganza. Un percorso che restituisce valore al vino parmense, storicamente apprezzato nei secoli scivolato in ombra solo nella prima metà del Novecento.
In alto i calici, per brindare ad una storia millenaria di grande tradizione e qualità.